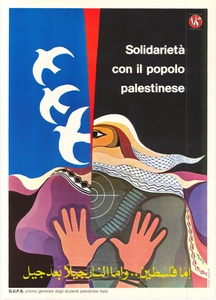
Viaggi e incontri di Enrico Berlinguer

Fin dal suo impegno giovanile, la dimensione internazionale ha fortemente influenzato il pensiero politico di Berlinguer. La volontà di mantenere legami con partiti e leader si accompagnò all'analisi delle molteplici realtà socialiste globali. In questa fitta rete di relazioni, un ruolo chiave lo svolsero i viaggi delle delegazioni del Pci, dei quali Berlinguer fu uno dei protagonisti. I sette viaggi nel Sud globale danno forma a uno dei tasselli del mosaico che rappresenta il Berlinguer viaggiatore, e restituiscono il valore simbolico e diplomatico che l'incontro politico ricopriva.
Enrico Berlinguer compì sette viaggi nel Sud globale, prima come membro dell'Ufficio politico, poi come segretario del Pci. Le singole pagine dedicate ai viaggi raccontano tappe, incontri, confronti, ricostruiti a partire dalle pagine de «l’Unità» e dalle testimonianze dei compagni di viaggio di Berlinguer. Di particolare importanza sono gli scritti di Antonio Rubbi (Il mondo di Berlinguer, Appunti cinesi) per quanto riguarda i viaggi nell'Asia socialista e in America Centrale. Hồ Chí Minh, Deng Xiaoping, Kim Il Sung, Houari Boumédiène, Ahmed Sékou Touré, Luis Cabral, Fidel Castro, Ernesto Cardenal, Dora Tellez, Yasser Arafat sono alcune delle personalità incontrate da Berlinguer durante i suoi viaggi. Queste relazioni restituiscono la rilevanza che la dimensione internazionale e il legame tra nord e sud del mondo rivestiva per il progetto politico del Pci.
La piattaforma è in aggiornamento continuo. I viaggi e i paesi su cui si è focalizzata la ricerca sono quelli dell'Asia socialista (Vietnam, Cina e Corea del Nord) e la Palestina. La ricerca è in corso sui viaggi e i paesi in America Centrale e in Africa.
A metà novembre 1966, il Partito dei lavoratori del Vietnam invita il Pci ad Hanoi; insieme alla richiesta dei vietnamiti, arriva anche una lettera dal Partito del lavoro della Corea del Nord. Unendo i due viaggi, la delegazione mette in conto di fermarsi a Pechino e incontrare i compagni del Pcc per tentare di ristabilire i rapporti interrotti quattro anni prima.
Poiché il governo italiano non riconosceva nessuno dei tre paesi, i visti fanno fatica ad arrivare. Alla consegna dei documenti per il viaggio, Carlo Galluzzi viene ricevuto da Amintore Fanfani alla Farnesina, mentre Antonello Trombadori riceve dalla segreteria vaticana un messaggio del Papa Paolo VI da consegnare a Hồ Chí Minh[1].
Il 4 dicembre 1966, Berlinguer, Galluzzi e Trombadori partono in direzione Mosca, primo scalo per raggiungere l’Asia socialista[2]. A Pechino, i tre sono testimoni diretti dell’avvio tumultuoso della Rivoluzione culturale: la capitale cinese è dominata dai ritratti e dalle statue di Mao, dalle scritte murali e dai cortei delle Guardie Rosse. Le strade sono tappezzate da manifesti e ideogrammi e gli altoparlanti diffondono incessantemente parole d’ordine maoiste. Galluzzi e Berlinguer riportano l’impressione che Pechino sia una città che vive in una tensione continua.
Nonostante la permanenza di cinque giorni, la delegazione non viene ricevuta da alcun dirigente del Partito comunista cinese, né durante lo scalo di andata né in quello di ritorno. Solamente un silenzioso funzionario della sezione esteri accoglie con freddezza i visitatori e li informa che non sono previsti incontri ufficiali.
Sull’aereo che li porta a Wuhan, primo scalo per Hanoi, la delegazione ha un breve incontro con Cen Ko. L’unica hostess distribuisce ai pochi passeggeri un foglio con le parole e il testo, in inglese e cinese, di L’Oriente è Rosso e li invita a cantare: «Antonello, che non perdeva mai occasione per combinarne qualcuna, unì la sua voce a quelle di Cen Ko e degli altri cinesi, invitandomi a fare altrettanto senza fare caso a Berlinguer che ci guardava stupito. La giovane hostess, finito di cantare, tornò in mezzo a noi con un libretto di Mao in mano. Lo aprì e cominciò a declamare ad alta voce, accompagnata dal coro dei cinesi che ripetevano con grande fervore. […] La scena aveva del surreale. Io e Trombadori ci eravamo immedesimati in quella specie di funzione religiosa e, all’unisono con i cinesi, facevamo seguire ad ogni massima una strofa di Oriente Rosso»[3].
Il 5 dicembre la delegazione atterra ad Hanoi, capitale di un paese che da anni resiste all’aggressione americana. La guerra è ovunque: dai crateri nelle strade, alle scuole bombardate, alle testimonianze raccolte nei musei dei crimini americani. Eppure, ciò che più colpisce Berlinguer e Galluzzi è la calma e la dignità del popolo vietnamita.[4] Nonostante le perdite e le distruzioni, la vita continua tra autodifesa popolare e attività produttive, in un clima di disciplina e consapevolezza politica. Il popolo nordvietnamita, secondo Berlinguer, combatte con la forza morale di chi difende una causa giusta e non vuole tornare al colonialismo. Durante il soggiorno, la delegazione visita Haiphong, dove riceve simbolici doni dai lavoratori del porto: una bandiera della Resistenza romana viene scambiata con un modellino della prima nave costruita nel cantiere. A colpire Galluzzi è anche il pranzo con Hồ Chí Minh, figura carismatica e insieme austera, che mostra grande interesse per la situazione internazionale e per i recenti eventi italiani come l’alluvione di Firenze.
Dopo la partenza di Galluzzi e Berlinguer, Trombadori rimane ad Hanoi come corrispondente per «l’Unità», testimoniando la devastazione provocata dai bombardamenti americani sulla popolazione, che sempre più assumono tratti terroristici e genocidari. Durante la conferenza stampa al ritorno in Italia, anche Berlinguer denuncia il carattere indiscriminato e atroce dei bombardamenti, affermando che, nonostante la violenza, gli Stati Uniti non riusciranno a piegare la volontà di resistenza del popolo vietnamita. Richiama la necessità dell’unità del movimento comunista e dell’intervento dell’opinione pubblica mondiale per fermare l’escalation: il popolo vietnamita, afferma, è pronto a trattare, ma solo nel rispetto della propria indipendenza e autodeterminazione.
Dopo un nuovo scalo a Pechino, Galluzzi e Berlinguer arrivano a Pyongyang. La capitale si mostra come una città moderna e ricostruita, un connubio tra tradizione e socialismo che a Galluzzi ricorda Mosca. Le ferite della guerra sembrano sanate, e l’industria e l’agricoltura sono in piena espansione. Il monumento del cavallo alato, simbolo della rinascita coreana, incarna la volontà del popolo di risorgere dalle rovine.
L’accoglienza è strana: Kim Il Sung è trattenuto da un impegno improrogabile, ma gli ospiti sono invitati a iniziare l’incontro con il compagno Park, membro dell’Ufficio politico del Partito del lavoro coreano. Berlinguer, riluttante, comincia lentamente a leggere in francese i suoi appunti: «Berlinguer concluse la sua relazione con quattro domande: sulla questione vietnamita e sul sostegno della lotta di quel popolo per la sua indipendenza, sulla situazione in Corea con particolare riguardo ai rapporti fra il Nord e il Sud, sul movimento comunista internazionale e sulle sue difficoltà, sulla situazione in Cina»[5].
Il giorno successivo incontrano Kim Il Sung, che li accoglie con un abbraccio. Il leader coreano li impegna in un monologo di due ore in cui discute di relazioni internazionali, tensioni con Cina e Unione Sovietica, e necessità di autonomia per ogni partito comunista. Il pranzo in onore della delegazione è un tripudio di cibo, ginseng e aneddoti sul calcio nordcoreano, tra risate fragorose e riferimenti alle virtù afrodisiache delle specialità locali. Quello nei confronti di Kim Il Sung è definito da Galluzzi come culto, «stalinismo bonario, paesano, ma non meno autoritario»[6].
In Corea del Nord, la delegazione coglie un sentimento profondo di indipendenza nazionale. I nordcoreani vogliono relazioni pacifiche con tutti i popoli, e manifestano grande simpatia per il Pci[7]. Rifiutano però ogni ingerenza esterna nei propri affari interni, e insistono sull’autonomia del loro partito nel contesto del movimento comunista internazionale.
Il 3 settembre 1969 muore Hồ Chí Minh, Presidente della Repubblica democratica del Vietnam. Nei giorni successivi, «l’Unità» dedica numerose pagine al dirigente comunista: apre la prima del 4 settembre con il titolo È morto il compagno Ho Ci Min, quella del 5 settembre con Uniti nel nome di Ho Ci Min, e quella del 10 con Il testamento di Ho Ci Min. Il mondo comunista si mobilita con manifestazioni pubbliche di compianto, lettere di cordoglio al Partito dei lavoratori della Repubblica democratica del Vietnam, e visite ufficiali delle delegazioni internazionali al funerale. Il 6 settembre partono dall’Italia anche Enrico Berlinguer e Gian Carlo Pajetta come rappresentanti del Pci.
Il giorno prima del funerale le delegazioni internazionali e i cittadini si riuniscono nella piazza di Ba Dinh per rendere omaggio alle spoglie di Hồ Chí Minh. I paesi rappresentati sono numerosi: Urss, Corea del Nord, Cina, Polonia, Rdt, Cecoslovacchia, Bulgaria, Ungheria, Mongolia. Così come le delegazioni dei partiti comunisti: francese, britannico, italiano, americano, giapponese, cubano, della Réunion. Infine, tre rappresentanti di Stato: Mauritania, Guinea e Mali[1].
Durante il funerale, il segretario del Partito dei lavoratori Lê Duẩn legge il testamento di Hồ Chí Minh e, al termine della cerimonia, ringrazia personalmente la delegazione del Pci, ricordando sia il sostegno e l’aiuto alla causa vietnamita da parte dei comunisti e dei cittadini italiani, che gli incontri tra Luigi Longo e Hồ Chí Minh [2].
L’11 settembre, prima della partenza, Berlinguer e Pajetta hanno un incontro con il governo rivoluzionario provvisorio del Vietnam del Sud: sono presenti il vicepresidente del consiglio Nguyễn Doa e la ministra degli esteri Nguyễn Thị Bình. La delegazione del Pci incontra anche Trịnh Đình Thảo, presidente dell’Alleanza democratica per la pace del Vietnam del Sud. Nel corso della stessa giornata si concludono inoltre i colloqui con la delegazione dell’Ufficio politico del Partito dei lavoratori vietnamiti, che rinnova i ringraziamenti per gli ultimi saluti del Pci ad Hồ Chí Minh, a testimonianza della solidarietà che unisce i due partiti nella lotta contro l’imperialismo[3].
La visita della delegazione del Partito comunista italiano in Cina nell’aprile del 1980 rappresenta l’esito di un complesso e lungo processo di riavvicinamento tra due partiti che, per quasi due decenni, sono stati separati da profonde divergenze ideologiche e strategiche. La rottura tra il Pci e il Partito comunista cinese risale infatti al 1962, quando le posizioni assunte da Togliatti suscitano una dura reazione da parte cinese. Esse si inseriscono nella crisi sino-sovietica, e riflettono, per certi versi, gli esiti della crescente rivalità tra Cina e Urss. Da allora, i rapporti tra le due formazioni rimangono congelati per anni, nonostante il Pci non abbia mai appoggiato l’allontanamento del Pcc e sostenga la normalizzazione delle relazioni diplomatiche della Repubblica popolare cinese con l’Occidente[1].
Fin dall’inizio della sua segreteria, Enrico Berlinguer insiste per la ripresa dei contatti. La Cina, a suo avviso, è «uno dei soggetti fondamentali nel passaggio degli equilibri mondiali dal bipolarismo al multipolarismo»[2], e il dialogo con il Pcc risponde a una visione di internazionalismo «a 360 gradi». Tuttavia, fino alla svolta interna cinese del 1978 — con la terza sessione plenaria del Comitato centrale e l’ascesa di Deng Xiaoping — ogni tentativo rimane senza esito. Solo nel 1979 si aprono spiragli significativi: i primi incontri tra funzionari del Pci e del Pcc avvengono in gran segreto, con il coinvolgimento di Antonio Rubbi e Angelo Oliva, e permettono di porre le basi per il viaggio ufficiale dell’anno successivo. Altri due importanti segnali di riavvicinamento sono l’invio a Pechino, su invito del «Quotidiano del Popolo», dei giornalisti Claudio Petruccioli de «l’Unità» e Massimo Ghiara di «Rinascita», seguiti dalla missione in Cina della Fgci guidata da Massimo D’Alema, nel dicembre dello stesso anno[3].
Il 13 aprile 1980 parte per la Cina una delegazione composta da Berlinguer, Gian Carlo Pajetta, Antonio Rubbi, Angelo Oliva, Silvana Dameri, Francesco Ingrao – medico di Berlinguer – Renzo Foa e Lina Tamburrino, rispettivamente per «l’Unità» e «Rinascita». L’annuncio ufficiale viene dato solo poche settimane prima, il 17 marzo, e desta vasto interesse a livello internazionale. Persino il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, chiede subito un colloquio con Berlinguer. Il viaggio nasce dal desiderio di conoscere da vicino la nuova realtà cinese e aprire un confronto diretto, capace di superare le incomprensioni del passato. Nelle sue dichiarazioni, Berlinguer ribadisce la volontà di portare un messaggio di pace e cooperazione internazionale, mantenendo sempre il rispetto dell’autonomia e delle rispettive posizioni[4].
Il primo incontro significativo avviene con Hu Yaobang, segretario del Pcc e vecchio compagno di Berlinguer durante gli anni di impegno politico nella Federazione mondiale della gioventù democratica. Il successivo colloquio con il presidente Hua Guofeng è abbastanza protocollare: rivela che ormai le redini del Partito stanno per essere lasciate a Deng Xiaoping. Il secondo giorno la delegazione visita l’importante Università di Pechino, dove Berlinguer tiene un discorso davanti a professori e studenti, attraverso cui fornisce un’ampia panoramica della situazione italiana e della politica del Pci.
L’appuntamento più atteso e più complesso è quello con Deng Xiaoping, che arriva mezz’ora prima dell’incontro ufficiale, improvvisando una conferenza stampa con i giornalisti. Un gesto che sorprende la delegazione italiana e irrita Berlinguer. Nel successivo colloquio privato, Deng instaura un tono informale, cercando di ridimensionare le divergenze tra i due partiti. Ma Berlinguer riporta l’attenzione sui conflitti internazionali in corso, insistendo in particolare sull’urgenza di risposte politico/diplomatiche ai casi afgano e cambogiano. Deng, invece, ribadisce il realismo della posizione cinese: la guerra è ritenuta inevitabile e prima o poi sarebbe esplosa, si può lavorare solo per prolungare il più possibile la pace[5].
Durante gli incontri non mancano momenti di tensione. Le affermazioni di Deng durante la conferenza stampa — in particolare l’accenno al carattere strategico della collaborazione con gli Stati Uniti in chiave antisovietica — sollevano preoccupazioni tra i vertici del Pci. Anche l’idea di un nuovo «movimento comunista internazionale» proposto dai cinesi sembra incompatibile con la visione pluralista del «nuovo internazionalismo» teorizzato dal Pci. Per ristabilire un equilibrio comunicativo, la delegazione italiana convoca una conferenza stampa altrettanto affollata e senza precedenti per Pechino, durante la quale Berlinguer risponde alle domande dei giornalisti, chiarendo sia le divergenze che le convergenze tra Pci e Pcc[6].
Nonostante le innegabili differenze, il bilancio della visita è positivo: si era stabilito un confronto franco dopo anni di silenzio, riavviando ufficialmente i rapporti tra Pci e Pcc su nuove basi, più solide e trasparenti. I commenti internazionali sono per lo più favorevoli, mentre reazioni negative arrivano dai partiti comunisti filosovietici e dallo stesso Pcus, che con una lettera inviata il 23 maggio al Comitato centrale del Pci manifesta apertamente il proprio disappunto.
Terminata la visita in Cina, il 23 aprile la delegazione italiana si trasferisce in Corea del Nord per rispondere all’invito, impossibile da declinare, di Kim Il Sung. L’accoglienza a Pyongyang è spettacolare: migliaia di persone, danze tradizionali, e un’apparente devozione che trasmette l’impressione di un autentico culto del leader. Berlinguer coglie l’importanza del passaggio nordcoreano nel quadro del movimento dei paesi non allineati[7].
Durante dodici intense ore di colloqui, Kim Il Sung illustra i progressi della società nordcoreana e il percorso di indipendenza nazionale. In pubblico elogia il Pci come guida morale del progresso mondiale; Berlinguer, più cauto, si mantiene su toni sobri e realistici. La visita si conclude con il tradizionale scambio dei regali, che nel racconto Rubbi impreziosisce con l’aneddoto del dono spezzato: un gabbiano di vetro di Murano al quale si era rotta un’ala durante il viaggio, che viene riparato da un artigiano locale e consegnato intatto a Kim Il Sung. Al contrario, i servizi di porcellana donati dai coreani e imbarcati senza precauzioni si danneggiano durante il viaggio di ritorno, simbolo sottile dell’ambiguità nei rapporti diplomatici.
Il ritorno in Italia è accolto da una stampa in larga parte entusiasta. Il viaggio aveva raggiunto l’obiettivo di ristabilire rapporti politici con due realtà fondamentali del mondo comunista asiatico. La visita in Cina, in particolare, apre la strada a una serie di scambi sempre più regolari e proficui, ai quali seguirà il secondo viaggio di Berlinguer nel 1983.
Nell’agosto del 1983, Enrico Berlinguer accetta l’invito del suo omologo cinese Hu Yaobang a trascorrere un periodo di vacanza in Cina. Non si tratta però di una semplice villeggiatura: il viaggio ha una valenza politica ben precisa, frutto della strategia delineata da Berlinguer negli anni successivi alla sempre più ampia frattura con l’Urss. Dopo la dichiarazione del 1981 sull’esaurimento della “spinta propulsiva” della Rivoluzione d’Ottobre, il Pci cerca nuovi interlocutori per un diverso equilibrio mondiale: l’Europa e la Cina diventano i pilastri di questa visione[1].
Da tempo i rapporti tra il Pci e il Partito comunista cinese si sono rafforzati. Scambi di delegazioni, collaborazione tra i rispettivi organi di stampa, presenze cinesi al Festival de l’Unità, hanno contribuito a consolidare una relazione fondata sul reciproco rispetto, nonostante le profonde divergenze ideologiche.
Il viaggio ha un tono diverso da quello “storico” del 1980: meno formale, più rilassato, ma non per questo privo di significato. Berlinguer è accompagnato da Antonio Rubbi e dalle rispettive famiglie. Il programma prevede incontri politici, visite istituzionali, momenti di svago. I dirigenti cinesi riservano loro un’accoglienza da capi di Stato: Hu Yaobang li riceve personalmente e li accompagna in alcune tappe.
Il 16 agosto, al Palazzo dell’Assemblea del Popolo, avviene il primo colloquio ufficiale. Hu espone lo stato dell’economia e della politica cinese; Berlinguer illustra le linee del Pci, ribadendo l’impegno per un socialismo democratico. Discutono delle relazioni sino-sovietiche e ironizzano sulla recente partita di calcio tra la nazionale cinese e lo Shakhtar di Donetsk, finita in pareggio[2].
Il giorno successivo visitano Xi’an, antica capitale imperiale. Accompagnati da Feng Chen e da un team di interpreti, osservano i progressi dell’agricoltura e ammirano l’esercito di terracotta. A tavola, emergono ricordi e riflessioni sulla Rivoluzione culturale, rievocata da testimoni e vittime di quella fase politica.
Il 18 agosto, a Nanchino, Hu Yaobang si unisce nuovamente alla delegazione. Visitano il ponte sullo Yangtze e pranzano in cima al grattacielo Jinling. La sera, assistono a una proiezione in anteprima del film “La tempesta scoppia sul monte Shongshan”, che ricostruisce la liberazione della città nel 1949.
Il 19 agosto si tiene un secondo incontro con i dirigenti del Pcc, riservato e senza dichiarazioni pubbliche. In serata, partono per Shanghai, dove il giorno seguente visitano Baoshan: lì è in costruzione il più grande impianto siderurgico della Cina, destinato a ridurre la dipendenza dall’acciaio straniero. La modernizzazione industriale è accompagnata dalla nascita di una città nuova, progettata ex novo.
A Shanghai, Berlinguer incontra gli amministratori locali. Vengono illustrati i progressi della città, ma anche le criticità: condizioni abitative precarie, controllo delle nascite inefficace nelle campagne, gestione complessa della megalopoli. È uno sguardo concreto sulle sfide dello sviluppo cinese.
La delegazione si sposta poi a Yantai, dove si concede una giornata di riposo. La pesca si rivela infruttuosa, il ping pong inaccessibile, così si opta per una partita amichevole di pallavolo. Berlinguer, pur goffamente, riesce a segnare un punto e guadagna l’ovazione del pubblico e una foto in prima pagina sul giornale locale, nonostante il divieto di pubblicazione precedentemente concordato.
Prima del rientro a Pechino, Berlinguer si prepara per un’intervista per i quotidiani cinesi[3]: intende evidenziare il ruolo che la Cina può svolgere per la pace mondiale e per uno sviluppo equilibrato tra nord e sud del mondo. In conferenza stampa, ribadisce l’interesse per la modernizzazione cinese e per il suo ruolo autonomo nello scacchiere globale. Riconosce il rinnovamento dei quadri del Pcc e sottolinea il valore dei rapporti tra i due partiti, pur nella differenza.
Tornato a Pechino, Berlinguer rifiuta, per impegni inderogabili in Italia, un invito del Partito del lavoro coreano a recarsi a Pyongyang. Con i dirigenti cinesi si lavora al comunicato finale, in cui si riaffermano l’impegno per il disarmo, la cooperazione tra partiti nel rispetto dell’autonomia, il ruolo positivo dei paesi non allineati e la valorizzazione dei rapporti tra Italia e Cina[4].
Durante la conferenza con la stampa internazionale, Berlinguer evidenzia i cambiamenti notati rispetto al viaggio del 1980: maggiore attenzione verso il Terzo mondo, sostegno ai movimenti di liberazione, impegno per la pace. A una domanda sulla Cambogia, ribadisce la necessità del ritiro delle truppe vietnamite e di un accordo nazionale per garantire la sovranità e la sicurezza del paese. Interpellato sul “nuovo internazionalismo”, chiarisce che non si tratta di una nuova egemonia, ma di un metodo basato sul rispetto delle diversità e sulla collaborazione tra forze progressiste, anche al di fuori del mondo comunista[5].
Prima della partenza, Berlinguer e Rubbi hanno colloqui con Qiao Shi, Wu Xueqian, e Peng Zhen, rispettivamente il membro candidato della segretaria del Pcc, il ministro degli Esteri e il presidente dell’Assemblea Nazionale[6]. Durante l’ultimo saluto a Hu Yaobang, viene rinnovato l’invito a visitare il Pci in Italia.
Sul volo di ritorno, Rubbi riflette sul viaggio appena concluso: la Cina è un paese in movimento, determinato a superare le sue arretratezze con una politica di apertura e sviluppo. Ma il cammino sarà lungo, con contraddizioni e tensioni. Un paese in transizione, ancora lontano dal ruolo guida immaginato da Berlinguer per il Sud globale, ma fondamentale nell’architettura di un nuovo internazionalismo[7].
Atterrati in Italia, Berlinguer è accolto dai dirigenti del Pci e dai giornalisti. Smentisce che il rafforzamento dei rapporti con la Cina implichi un’ulteriore rottura con l’Urss. Ricorda che il Pci mantiene relazioni autonome con tutte le forze comuniste e progressiste. Rispondendo a una domanda sulle condanne a morte eseguite in Cina durante la visita, rivela di aver sollevato la questione con i dirigenti cinesi, riaffermando che l’abolizione della pena capitale è, per il Pci, un principio irrinunciabile[8].